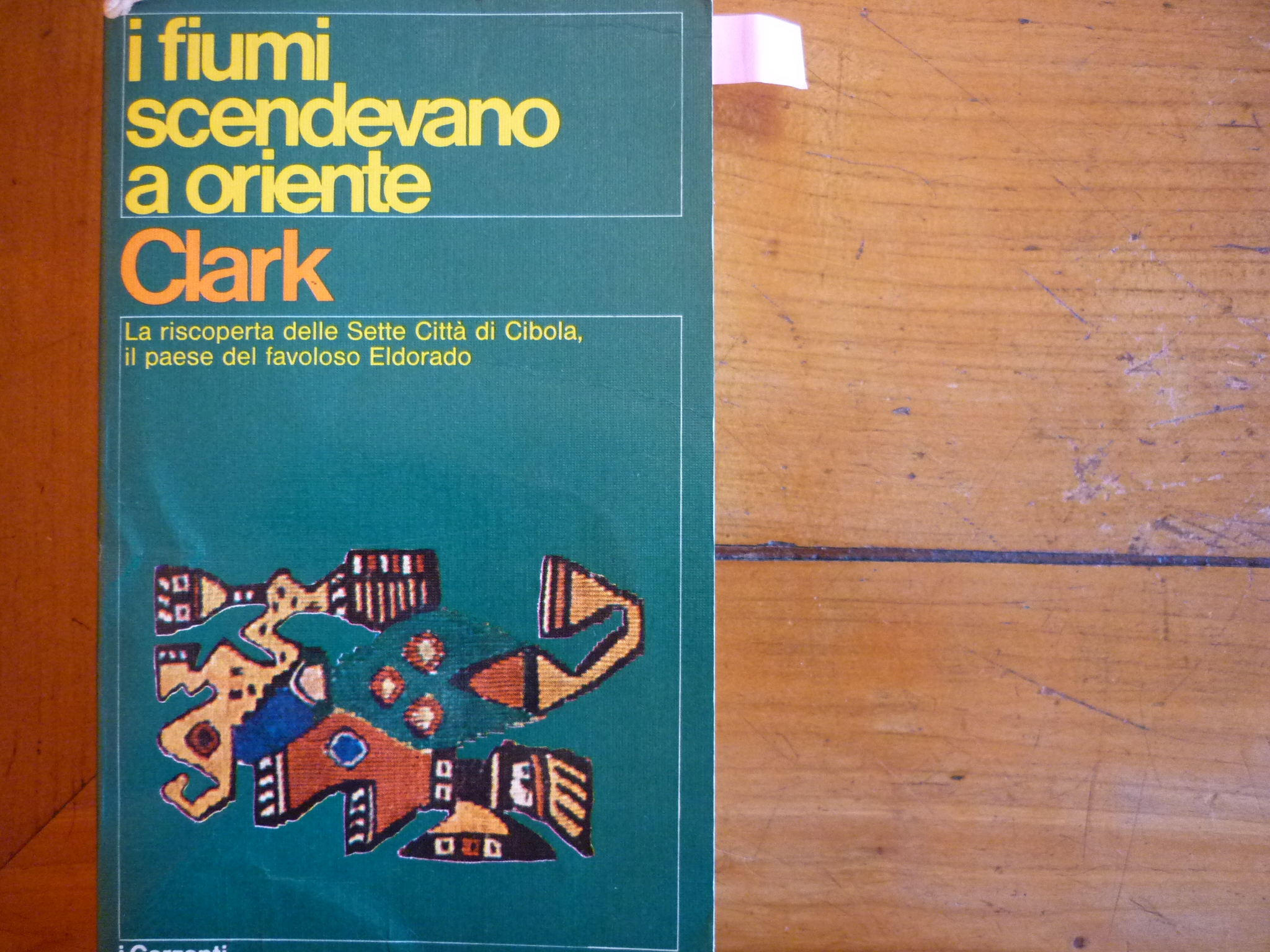Le grandi manifestazioni di venerdì 27 settembre hanno chiuso la settimana di azione per il clima, promosse da gruppi di giovani, a livello mondiale, ispirati dalla protesta di Greta Thunberg. Greta, su Twitter, riferisce che i primi dati parlano di almeno 7 milioni di partecipanti, scesi in piazza ai quattro angoli del Pianeta.
La prima domanda è la seguente: il clima sta veramente cambiando? Per trovare risposte fondate conviene cercare fonti autorevoli, e dunque rivolgersi agli scienziati. Gli studi scientifici che investono in qualche modo il tema sono migliaia, e per la loro stessa mole chiedono un impegno che supera la portata di un comune mortale, e anche quella di un uomo politico medio. Per questo le Nazioni Unite hanno dato vita ad un organismo specifico, lo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), di cui fanno parte centinaia di studiosi di varie discipline, provenienti da tutto il mondo, che ha esattamente il compito di leggere e valutare tutti gli studi scientifici prodotti sul tema del cambiamento climatico. Il loro lavoro viene poi sintetizzato in report che vengono pubblicati e diffusi in rete.
I report pubblicati da IPCC parlano chiaro: la Terra si sta riscaldando progressivamente e con un ritmo piuttosto deciso. Si tratta, ovviamente, delle temperature medie che vengono rilevate e calcolate a livello globale, e che vengono paragonate alle analoghe misurazioni effettuate, ad esempio, negli anni 1900-1910 e 1950-1960.
Le cause del riscaldamento globale? Le numerose attività umane che immettono nella atmosfera quelli che vengono definiti “gas serra”, come CO2, metano, e altri. Derivano, come noto, da varie fonti e dalla combustione di combustibili fossili, petrolio e carbone in primo luogo, ma anche dagli animali ammassati negli allevamenti, che costituiscono una consistente fonte di metano rilasciato in atmosfera.
Che fare?
Per prima cosa mettere a fuoco la nostra visione: prendere in mano e affinare la nostra visione del mondo, della nostra vita e della vita degli altri esseri.
Una certa visione del mondo, diffusa e pervasiva, continua a dipingere la Terra come un grande serbatoio di risorse, disponibili e accessibili, e basta allungare la mano, o scavare un pozzo, e si può prendere quel che si vuole, e avere una “crescita” continua e senza fine: basta avere i soldi, per pagare, naturalmente. Tutto si vende e tutto si compra nel grande Supermercato globale. E i rifiuti si buttano nella spazzatura, magari “differenziata”, e i gas tossici e serra si buttano, con tranquilla coscienza, in giro per l’aria, in balia dei venti.
Ebbene, questa visione del mondo è povera e falsa.
Questa visione del mondo ci sta portando, a grandi passi, verso la catastrofe climatica: gli ecosistemi non sono in grado di modificarsi e adattarsi ad un rapido innalzamento delle temperature medie globali. Le conseguenze sono le estinzioni di massa: quella umana è una delle numerose specie viventi inserite nella lista, perché gli uomini – e sono vari miliardi – camminano e respirano e mangiano se esiste un mondo ancora vivibile.
L’atmosfera non è un grande nulla, una grande discarica gassosa, disponibile gratis, dove bruciare e fumigare a piacimento quel che si crede; la Terra non è una grande miniera a cielo aperto, dove cavare ogni elemento e dove sversare, seppellire, ammucchiare e disperdere ogni genere di immondizia, ogni specie di rifiuto tossico, da lasciare in eredità alle generazioni future.
Che fare?
Due cose: pensare ed agire. Pare strano, ma a volte si evita di fare e l’una cosa e l’altra, almeno seriamente, e ci si contenta di quattro chiacchiere di superficie. Ovviamente, per poter pensare occorre prima informarsi: IPCC, data la complessità dei report che produce, realizza delle sintesi destinate ai “policymaker”, i “decisori politici”, gli uomini che stanno al governo. Queste sintesi sono on line, tutti le possono scaricare e leggere.
Possiamo così sederci tranquilli e aspettare che il governo di Roma, e i governi, discutano e approvino le misure più efficaci?
Che fare?
Aspettare che i governi decidano e ci dicano cosa fare? Sicuramente, e necessariamente, i governi e i parlamenti devono fare la loro parte, e le manifestazioni di piazza sono un pungolo utile e potente. Ma possiamo fidarci della tempestività, della efficacia, della assennatezza, della onestà degli uomini di governo? Le risposte alle prime due questioni sono, molto probabilmente, “no”: anche nel migliore dei mondi possibili, i tempi di reazione dei governi sono piuttosto lunghi, e dunque sarà necessario continuare a premere e manifestare, perché si tratta di mettere mano ad un sistema intricato e solido di interessi costituiti. Ma la questione climatica è una emergenza, letteralmente, e come tale deve essere affrontata.
In secondo luogo c’è il problema della efficacia, cioè della incidenza effettiva delle decisioni di governo. Ebbene, forse qualcuno lo dimentica, non è tutto nelle mani di un governo insediato a Roma, o a Parigi, o a Londra: a casa mia il governo sono io; a casa tua il governo sei tu. E dico “casa” a ragion veduta, perché una delle fonti di “gas serra” è costituita proprio dalle abitazioni, e dagli uffici: nessun governo, da Roma, verrà a controllare come e quanto si riscaldano le mura domestiche. Nessuno verrà a vedere cosa si mette nel carrello del supermercato quando si fa la spesa, o se si seguono le mille altre pratiche che non portano impatto sull’ambiente e sul clima. Insomma, il governo, nel nostro pezzetto di mondo, siamo noi, e sta a noi cominciare ad agire.
Se la casa brucia, ed è quello che sta avvenendo, si smette di buttare benzina sul fuoco, e si corre a spegnere l’incendio, non si sta ad aspettare che lo dica il ministro di turno.
Nella foto, un frammento della manifestazione di Venezia.



 Un tratto di linea ferroviaria dismesso. Una proposta: realizzare una pista ciclabile che riutilizzi il sedime, e unisca due punti di Chirignago in maniera sicura per ciclisti e pedoni. Si tratta di meno di 3 chilometri, dalla località Valsugana fino ad Asseggiano.
Un tratto di linea ferroviaria dismesso. Una proposta: realizzare una pista ciclabile che riutilizzi il sedime, e unisca due punti di Chirignago in maniera sicura per ciclisti e pedoni. Si tratta di meno di 3 chilometri, dalla località Valsugana fino ad Asseggiano.